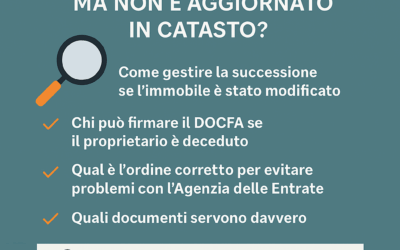Il consumo di suolo rappresenta una delle pressioni ambientali più rilevanti – e spesso sottovalutate – nel contesto della gestione sostenibile del territorio. Con questo termine si intende la trasformazione permanente di superfici naturali o agricole in aree urbanizzate, infrastrutturate o impermeabilizzate. Questo fenomeno è in costante crescita, alimentato da espansione urbana, infrastrutture e attività produttive, con conseguenze profonde non solo sul paesaggio, ma anche sulla capacità degli ecosistemi di fornire servizi essenziali per la vita.
Suolo: una risorsa non rinnovabile
È importante ricordare che il suolo, per quanto ci appaia stabile e onnipresente, è una risorsa non rinnovabile in tempi umani. I processi naturali di formazione del suolo richiedono secoli o millenni, mentre la sua trasformazione in superficie artificiale è questione di giorni. Questa discrepanza temporale rende il consumo di suolo un problema strutturale: ogni metro quadro cementificato è, di fatto, una perdita permanente.
Servizi ecosistemici: cosa perdiamo quando perdiamo suolo
Gli ecosistemi naturali – foreste, prati, zone umide, suoli agricoli – offrono gratuitamente una serie di funzioni essenziali chiamate “servizi ecosistemici”. Questi comprendono:
-
Regolazione climatica e idrica: il suolo regola il ciclo dell’acqua, assorbe le piogge, ricarica le falde, mitiga le alluvioni.
-
Sequestro del carbonio: il suolo immagazzina CO₂ contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.
-
Biodiversità: ospita una quantità straordinaria di organismi, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi.
-
Produzione alimentare: è la base della nostra agricoltura, e quindi della sicurezza alimentare.
-
Depurazione naturale: filtra e purifica l’acqua e l’aria, riducendo l’inquinamento.
Quando un’area viene impermeabilizzata, la maggior parte di questi servizi si interrompe. La pioggia non viene più assorbita, aumentando il rischio di alluvioni. Il ciclo del carbonio si altera, così come il microclima locale. La biodiversità si frammenta e diminuisce. E la qualità della vita si deteriora.
Impatti sociali ed economici
La perdita di servizi ecosistemici non è solo una questione ambientale, ma ha ricadute dirette sulla società e sull’economia. Costi per la gestione del rischio idrogeologico, spese sanitarie dovute a inquinamento e ondate di calore, riduzione della produttività agricola: sono solo alcune delle conseguenze tangibili. Secondo studi recenti, l’Europa perde miliardi di euro ogni anno a causa della degradazione del suolo.
Riferimenti normativi: verso la tutela del suolo
La questione del consumo di suolo ha assunto sempre più rilievo anche a livello normativo, con diversi strumenti che puntano a tutelare questa risorsa strategica:
-
Strategia Europea per il Suolo (EU Soil Strategy for 2030): mira a conseguire suoli sani entro il 2050, fissando l’obiettivo “consumo di suolo netto zero” entro il 2050 e proponendo un quadro giuridico vincolante.
-
Green Deal Europeo e Strategia sulla Biodiversità 2030: riconoscono il suolo come elemento centrale per la transizione ecologica.
-
Proposta di Direttiva Europea sul Monitoraggio del Suolo (2023): introduce obblighi per gli Stati membri in materia di raccolta dati, bonifica dei suoli contaminati e lotta al degrado del suolo.
-
A livello nazionale, l’Italia non ha ancora una legge quadro sul suolo, ma sono state presentate diverse proposte di legge, e molte Regioni hanno iniziative di contenimento del consumo di suolo.
Il contributo di ISPRA e la mia partecipazione
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) svolge un ruolo chiave nel monitoraggio del consumo di suolo in Italia. Ogni anno pubblica il Rapporto sul Consumo di Suolo, Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici, documento di riferimento per istituzioni, tecnici e cittadini. Il rapporto fornisce dati aggiornati e analisi sulle trasformazioni del territorio, quantifica la perdita di servizi ecosistemici e propone indicatori per la pianificazione sostenibile.
Ho avuto il privilegio di contribuire attivamente ad alcuni di questi studi, collaborando con ISPRA nell’ambito delle valutazioni degli impatti territoriali e nella stima delle perdite di servizi ecosistemici a scala locale. Queste esperienze mi hanno permesso di approfondire le implicazioni concrete del consumo di suolo e di contribuire alla diffusione di buone pratiche a supporto della pianificazione ambientale.
Conclusioni
La lotta al consumo di suolo è una sfida chiave per costruire un futuro sostenibile. Difendere il suolo significa proteggere un patrimonio insostituibile di servizi ecosistemici da cui dipende il nostro benessere e la nostra sicurezza. È tempo di ripensare il modo in cui usiamo il territorio, ponendo il suolo e i suoi servizi al centro delle nostre scelte.